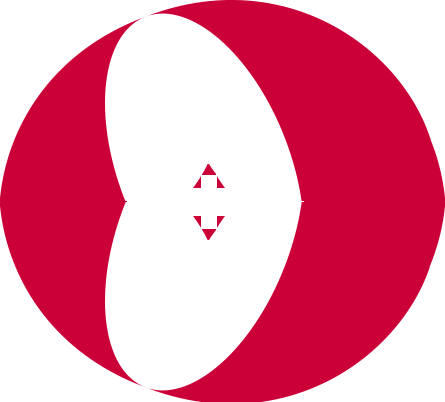| Alberto Moravia - Il conformista EPILOGO |
| CAPITOLO TERZO Verso l’alba, Marcello si destò e vide o credette di vedere la moglie che, ritta nell’angolo presso la finestra, guardava attraverso i vetri, in quella luce grigia del primissimo giorno. Era completamente nuda, con una mano scostava la tenda e con l’altra si copriva il petto, non si capiva se per pudore o apprensione. Una lunga ciocca di capelli disfatti le pendeva lungo la guancia; il viso, teso in avanti, pallido e senza colori, portava un’espressione di riflessione desolata, di costernata contemplazione. Anche il corpo pareva aver perduto in quella notte la sua robusta e vogliosa esuberanza: le mammelle che la maternità aveva alquanto spianate e allentate, mostravano, di profilo, una piega di flaccida stanchezza che non aveva mai notato prima; il ventre, non tanto rotondo quanto gonfio, dava un senso di gravezza goffa e inerme confermata dall’atteggiamento delle cosce che si stringevano, come tremebonde, a nascondere il grembo. La luce fredda del giorno nascente, simile ad uno sguardo indiscreto e apatico, illuminava squallidamente questa nudità. Pur guardandola, Marcello non potè fare a meno di domandarsi che cosa le passasse per la mente, mentre, immobile, in quello spicchio di chiarore antelucano, contemplava il cortile deserto. E con un vivo senso di compassione, si disse che quei pensieri egli poteva benissimo immaginarli. « Eccomi », ella certamente pensava, « eccomi scacciata dalla mia casa a metà quasi della vita, con una bambina in tenera età e un marito rovinato che non spera più nulla dal suo avvenire, la cui sorte è incerta, la cui vita, forse è in pericolo. Ecco il risultato di tanti sforzi, di tanta passione, di tante speranze». Era veramente, pensò, Èva scacciata dall’Eden; e l’Eden era quella casa con tutte le cose modeste che conteneva: la roba negli armadi, gli utensili nella cucina, il salotto per ricevervi le amiche, le posate argentate, i falsi tappeti persiani, il vasellame di porcellana che le aveva regalato la madre, la ghiacciaia, il vaso di fiori nell’anticamera, quella camera matrimoniale in falso stile impero, comperata a rate, e lui, dentro il letto, che la guardava. L’Eden era anche, senza dubbio, il piacere di stare a tavola due volte al giorno con la famiglia, di dormire la notte abbracciata al marito, di accudire alla casa, di formulare progetti per l’avvenire suo, di sua figlia e di lui. Finalmente, l’Eden era la pace dell’anima, l’accordo con se stessa e il mondo, la serenità del cuore placato e sazio. Da questo Eden, adesso, un angelo furibondo e spietato, armato di spada fiammeggiante, la scacciava per sempre, spingendola, nuda e indifesa, nell’ostile mondo esterno. Marcello l’osservò ancora un pezzo, mentre ella, immobile, prolungava la sua malinconica contemplazione; quindi, nel sonno che tornava a gravargli sulle palpebre, la vide staccarsi dalla finestra, andare in punta di piedi all’attaccapanni, toglierne una vestaglia, indossarla e uscire senza rumore. Andava probabilmente, come pensò, a sedersi presso il letto della bambina assopita, altra non lieta contemplazione; oppure a perfezionare i preparativi della partenza. Pensò un momento di raggiungerla, per consolarla in qualche modo. Ma si sentiva tuttora pieno di sonno e dopo un poco si riaddormentò. Più tardi, mentre nella pura luce del mattino estivo, la macchina correva alla volta di Tagliacozzo, egli ripensò a quella visione lamentevole domandandosi se l’avesse sognata oppure se l’avesse osservata davvero. La moglie gli sedeva al fianco, stringendosi contro di lui, per far posto a Lucilla, che, inginocchiata sul sedile, la testa fuori del finestrino, si godeva la corsa. Ella stava dritta, la giubba sbottonata sopra una camicetta bianca, il viso eretto ombreggiato da un cappello da viaggio. Marcello notò che teneva sulle ginocchia un oggetto di forma oblunga, avvolto in carta marrone e legato con spaghi. « Che hai in quel pacco? » domandò sorpreso. «Ti farà ridere», ella rispose, «ma non potevo risolvermi a lasciare a casa quel vaso di cristallo che stava nell’anticamera... ci ero affezionata prima di tutto perché è bello e poi perché me l’hai regalato tu... ti ricordi... poco dopo che nacque la bambina.... è una debolezza, lo so, ma servirà... ci metterò i fiori a Tagliacozzo ». Dunque era proprio vero, egli pensò, non aveva sognato, era proprio lei, in carne e ossa, e non una figura di sogno, che aveva veduto quel mattino, ritta presso la finestra. Disse dopo un momento : « Se ti faceva piacere portarlo via, hai fatto bene... ma ti assicuro che torneremo puntualmente a casa, appena sarà finita l’estate... non devi assolutamente allarmarti ». « Io non mi allarmo ». « Tutto si risolverà per il meglio », disse ancora Marcello cambiando la marcia poiché la macchina attaccava una salita, « e poi sarai felice come sei stata negli ultimi anni e anche di più». Giulia non disse nulla ma non pareva convinta. Marcello, pur guidando, l’osservò un momento: con una mano tratteneva il vaso sulle ginocchia, con l’altro braccio cingeva la vita alla bambina affacciata al finestrino. Tutti i suoi affetti e le sue possessioni, sembrava dire con quei gesti, erano ormai qui, in questa macchina: il marito al suo fianco, la bambina dall’altra parte, e, simbolo della vita familiare, il vaso di cristallo sulle ginocchia. Ricordò che al momento della partenza, ella aveva detto, lanciando un ultimo sguardo alla facciata della casa; «Chissà chi verrà ad occupare il nostro appartamento » ; e comprese che non l’avrebbe mai persuasa perché in lei non c’era convinzione meditata bensì soltanto presentimento atterrito dell’istinto. Domandò tuttavia con calma: «Si può sapere che cosa pensi adesso? » « Nulla », ella rispose, « non penso proprio nulla... guardo al paesaggio ». «No, cosa pensi in generale». «In generale? Penso che le cose vanno male per noi... ma che non è colpa di nessuno ». «Forse è colpa mia». « Perché colpa tua? Non è mai colpa di nessuno... tutti hanno nello stesso tempo torto e ragione... le cose vanno male perché vanno male, ecco tutto». Ella pronunziò questa frase con tono reciso, come a indicare che non aveva più voglia di parlare. Marcello tacque e da quel momento, per un pezzo, ci fu silenzio tra di loro. Era il mattino di buon’ora, ma la giornata si annunziava già calda; già, davanti alla macchina, tra le siepi impolverate e abbaglianti di luce, l'aria tremava e il riverbero del solleone suscitava riflessi specchianti sull’asfalto. La strada girava per un paesaggio ondulato, tra colline gialle, irte di stoppie secche, con rari cascinali bruni e grigi sperduti in fondo a valloni deserti e senz’alberi. Ogni tanto incrociavano un carretto tirato da un cavallo o una vecchia macchina provinciale: era una strada poco frequentata e il traffico militare passava per altre parti. Tutte era calmo, normale, indifferente, come pensò Marcello guidando, mai si sarebbe potuto pensare di trovarsi nel cuore di un paese in guerra e in rivoluzione. Le facce dei rari contadini che si scorgevano appoggiati alle staccionate, o in mezzo ai campi, la vanga al piede, non esprimevano che i soliti sentimenti di stolida e pacifica attenzione per le cose normali, consuete, ovvie della vita. Tutta gente che pensava ai raccolti, al sole, alla pioggia, ai prezzi delle derrate o, addirittura, a nulla. Giulia era stata per anni come quei contadini, pensò ancora, e adesso si doleva di essere strappata da quella pace. Gli venne fatto di pensare quasi con irritazione : peggio per lei. Vivere, per gli uomini, non voleva dire lasciarsi andare alla pace torpida offerta dalla natura indulgente, bensì essere continuamente in lotta e in agitazione, risolvere ogni momento un minimo problema dentro i limiti di problemi più vasti contenuti a loro volta nel problema complessivo, appunto, della vita. Questo pensiero gli ridiede fiducia in se stesso, mentre la macchina usciva dal paesaggio pianeggiante e desolato ed entrava tra le alte rocce rosse di una catena di colline. Forse perché guidando la macchina gli pareva che il proprio corpo facesse tutt’uno con il motore che inflessibilmente e agevolmente affrontava e risolveva le difficoltà della strada tutta curve e salite, gli parve che una specie di ottimismo, il primo dopo tanti anni, insieme avventuroso e spavaldo, sgombrasse finalmente, simile ad una raffica di vento impetuoso, il cielo tempestoso del suo animo. Si trattava, pensò, di considerare finito e sepolto tutto un periodo della sua vita e di ricominciare daccapo, su un piano e con mezzi diversi. L’incontro con Lino, pensò ancora, era stato molto utile; e non tanto perché l’avesse liberato del rimorso di un delitto che non aveva commesso, quanto perché con quelle poche parole dette per caso sull’inevitabilità e normalità della perdita dell’innocenza, Lino gli aveva fatto capire che per vent’anni egli si era ostinato in una strada sbagliata dalla quale doveva ora uscire decisamente. Questa volta non ci sarebbe stato bisogno di giustificazione e di comunione, pensò ancora, ed egli era risoluto a non permettere che il delitto commesso davvero, quello di Quadri, lo avvelenasse con i tormenti di una vana ricerca di purificazione e di normalità. Quello che era stato era stato, Quadri era morto, e, più pesante di una pietra tombale, egli avrebbe calato su quella morte la lapide definitiva di un oblio completo. Forse perché il paesaggio, adesso, era cambiato dal deserto afoso di prima, e un’abbondanza di acque invisibili faceva traboccare ai margini della strada erbe, fiori, felci e, più su, in cima al tufo, la verdura folta e rigogliosa del bosco ceduo, gli pareva che d’ora in poi avrebbe saputo evitare per sempre la desolazione dei deserti in cui l’uomo insegue la propria ombra e si sente perseguitato e colpevole; e avrebbe invece, liberamente e avventurosamente, ricercato luoghi simili a questi che ora percorreva, luoghi rupestri e impervii, da briganti e da animali selvatici. Egli si era costretto, volontariamente, ostinatamente, stupidamente, dentro legami indegni e in impegni ancor più indegni; e tutto questo per il miraggio di una normalità che non esisteva; adesso questi legami erano spezzati, questi impegni dissolti, e lui tornava libero e avrebbe saputo fare uso della libertà. In quel momento il paesaggio si presentava nel suo aspetto più pittoresco: da un lato della strada il bosco ceduo che ricopriva il fianco della collina; dall’altro un pendio erboso sparso di rare, enormi quercie fronzute, digradante fino ad una fossa fitta di cespugli tra i quali traluceva l’acqua schiumosa di un torrente. Al di là della fossa si levava una parete rocciosa dalla quale piombava giù il nastro scintillante di una cascata. Improvvisamente Marcello fermò la macchina dicendo : « È un luogo molto bello... fermiamoci un momento ». La bambina domandò voltandosi dal finestrino: « Siamo già arrivati ? » « No, non siamo arrivati, ci fermiamo un momento », disse Giulia prendendola in braccio e facendola scendere dalla macchina. Come furono discesi, la moglie disse che avrebbe approfittato della sosta per far soddisfare i bisogni naturali alla bambina e Marcello rimase presso la macchina mentre Giulia, tenendo per mano la bambina, si allontanava di qualche passo. La madre camminava piano, senza inclinarsi verso la bambina, la quale, vestita di una corta vesticciola bianca, un gran fiocco in cima ai capelli sciolti sulle spalle, chiacchierava al solito con animazione, levando ogni tanto il viso verso la madre, forse per muovere qualche domanda. Marcello si domandò quale posto avrebbe avuto sua figlia nell’avvenire nuovo e libero che l’improvvisa esaltazione gli aveva dipinto pocanzi e si disse, con vivo affetto, che, se non altro, avrebbe saputo avviarla verso una vita ispirata da motivi tutti diversi da quelli che avevano sinora guidato la sua. Tutto nella vita di sua figlia, pensò, avrebbe dovuto essere brio, estro, grazia, leggerezza, limpidezza, freschezza e avventura; tutto avrebbe dovuto rassomigliare ad un paesaggio che non conosce afe né caligini ma soltanto le rapide tempeste purificatrici che rendono più chiara l’aria e più ridenti i colori. Nulla avrebbe dovuto rimanervi della sanguinaria pedanteria che fino a ieri aveva informato il suo destino. Si, pensò ancora, ella doveva vivere in piena libertà. Tra queste riflessioni, lasciò il margine esterno della strada e si avvicinò al bosco che ombreggiava l’altro lato. Gli alberi erano alti e fronzuti, sotto gli alberi si avviluppavano rovi e altri arbusti selvatici, e sotto questi ultimi, in un’ombra silvestre, si intravvedevano erbe e fiori su un letto di borracina. Marcello tese una mano tra il viluppo dei rami e colse uno di quei fiori, una campanula di un azzurro quasi viola. La campanula era semplice, coi petali striati di bianco, e portandola alla narice, egli senti un amaro odore erbaceo. Pensò che quel fiore cresciuto nel viluppo ombroso del sottobosco, su quel po’ di terra aggrappata al tufo infecondo, non aveva cercato di imitare le piante più alte e robuste né di riconoscere il proprio destino al fine di accettarlo o rifiutarlo. In piena inconsapevolezza e libertà, era cresciuto dove era caduto a caso il seme, fino al giorno in cui la sua mano l’aveva colto. Essere come quel fiore solitario, su un lembo di musco, in un sottobosco buio, pensò, era un destino veramente umile e naturale. Invece l’umiltà volontaria di un adeguamento impossibile ad una normalità fallace non nascondeva se non orgoglio e amor proprio capovolti. Trasalì alla voce della moglie che diceva : « Allora, andiamo », e riprese il suo posto al volante. La macchina girò velocemente per la strada in curva, contornando il declivio sparso di quercie, e poi, dopo una folta boscaglia, attraverso uno spacco della collina, sbucò in vista ad un’immensa pianura. L’afa di luglio ne annebbiava gli orizzonti lontani, contornati di monti azzurri; nella luce dorata e un po’ caliginosa, Marcello scorse, nel mezzo della pianura, un monte solitario, dirupato, sormontato, a guisa di acropoli, da un borgo di poche case raggruppate sotto le torri e le mura di un castello. Si vedevano distintamente le fiancate grigie delle case sospese a picco sulla strada di circonvallazione che girava a spirale intorno il monte: il castello aveva una forma quadrata, con una torre tozza e cilindrica per lato; il borgo era di un colore rosato e il sole che incendiava il cielo strappava scintillii micidiali dai vetri delle case. Ai piedi del monte, la strada correva diritta, in bianco rettifilo, verso i limiti estremi della pianura; di fronte al monte, dall’altra parte della strada, si stendeva il vasto prato raso, di un verde ingiallito, di un campo di aviazione. A contrasto con le case antiche del borgo, sul campo tutto appariva moderno e nuovo: i tre lunghi capannoni mimetizzati di verde, di azzurro e di marrone, l’antenna in cima alla quale sventolava un pennone rosso e bianco, i numerosi apparecchi argentei, posati come a caso intorno i margini del campo. Marcello osservò a lungo questo paesaggio, mentre la macchina, girando da una svolta all’altra della ripida strada, scendeva velocemente verso la pianura, il contrasto tra la rocca antica e il campo di aviazione modernissimo gli parve significativo: sebbene, per un’improvvisa distrazione, non gli riuscisse di appurare quale precisamente fosse il significato. Al tempo stesso, come si accorse, provava un sentimento singolare di dimestichezza, come se avesse già veduto in passato quel paesaggio. Ma, come ricordò, era la prima volta che percorreva quella strada. La macchina, giunta in fondo alla discesa, infilò il rettifilo che pareva interminabile. Marcello accelerò la corsa e la lancetta del tachimetro sali gradualmente agli ottanta, poi ai novanta chilometri all’ora. La strada, adesso, correva tra due distese di campi mietuti, di un giallo metallico, senza un albero né una casa. Evidentemente, pensò Marcello, gli abitanti vivevano tutti nel borgo e ne scendevano al mattino per recarsi a lavorare nei campi. Poi, a sera, tornavano al borgo... La voce della moglie lo distrasse da queste riflessioni: «Guarda», ella disse indicando il campo di aviazione, « che succede ? » Marcello guardò e vide che parecchie persone correvano di qua e di là, per il grande prato raso, agitando le braccia. Nello stesso tempo, strana in quella luce abbagliante del sole estivo, dal tetto di uno dei tre capannoni, una fiamma lingueggiò rossa, aguzza, quasi senza fumo. Poi un’altra fiamma si slanciò dal secondo tetto e un’altra ancora dal terzo. Adesso le tre fiamme si erano riunite in una sola che si muoveva con violenza, di qua e di là; mentre nuvoli di fumo nero scendevano a terra nascondendo i capannoni, diffondendosi intorno. Intanto, ogni segno di vita era scomparso e il campo era tornato deserto. Marcello disse con calma: « Un’incursione aerea ». « Ma c’è pericolo? » « No, saranno già passati ». Egli accelerò l’andatura, la lancetta del tachimetro sali a cento, centoventi chilometri. Adesso erano sotto il borgo, si distinguevano la strada di circonvallazione, le fiancate delle case, il castello. Nello stesso tempo, Marcello udì alle spalle il fragore sferragliante e rabbioso dell’aeroplano che si abbassava. Tra il rumore, distinse il grandinare fitto della mitragliera che sparava e capi che l’aeroplano gli era dietro e presto gli sarebbe stato sopra: il fracasso del motore era in asse con la strada, come questa diritto e inflessibile. Poi il fragore metallico gli fu sopra, assordante, un solo momento, e quindi si allontanò. Egli senti un colpo forte alla spalla, come un pugno, e poi un languore mortale; disperato, riuscì a radunare le forze e a guidare e fermare la macchina sul margine della strada. « Scendiamo », disse con voce spenta, ponendo la mano sullo sportello e aprendolo. Lo sportello si spalancò e Marcello cadde di fuori: poi trascinandosi con la faccia e con le mani sull’erba, cavò le gambe dalla macchina e giacque in terra presso il fossato. Ma nessuno parlò, né, sebbene lo sportello fosse rimasto aperto, si affacciò dalla macchina. In quel momento, di lontano, risuonò il fragore dell’aeroplano che virava. Egli pensò ancora: « Dio, fa che non siano colpite... sono innocenti»; e poi, rassegnato, la bocca nell’erba, aspettò che l’aeroplano tornasse. La macchina con lo sportello aperto era silenziosa, ed egli ebbe il tempo di capire, con acuto dolore, che nessuno ne sarebbe disceso. Finalmente l’aeroplano fu su di lui, tirandosi dietro, mentre si allontanava nel cielo infuocato, il silenzio e la notte. FINE |
| Alberto Moravia Il conformista |