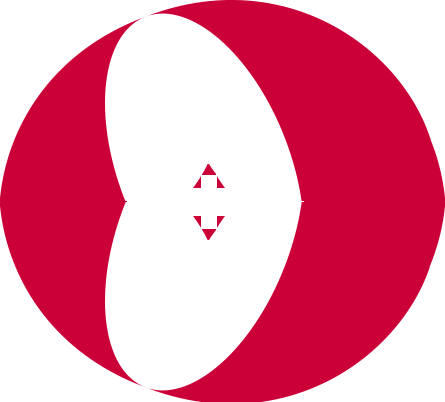IL NOME
Il nome è la parte variabile del discorso che indica esseri animati o inanimati: persone, animali, cose, idee, fatti, sentimenti, qualità ecc.
Il nome è formato di due parti: radice e desinenza.
- radice: indica il significato di base della parola
Es. ragazzo casa, libro
- desinenza: indica il genere e il numero della parola stessa
Es. ragazz-a, cas-e, libr-i
Il nome può essere:
secondo il SIGNIFICATO
Х concreto: quando indica persone, animali, cose: tutto ciò che esiste materialmente e che può essere percepito dai nostri sensi
Es. tavolo, auto, cane, mare, strada, pane, lampo, odore
Х astratto: quando indica ciò che esiste solo nel pensiero e che non può essere percepito dai nostri sensi: idee, sentimenti, qualità, fatti ecc.
Es. onestà, bellezza, sentimento, amicizia, eroismo, odio
Х comune: quando può essere riferito a qualsiasi unità della stessa specie
Es. ragazzo, città, ragioniere, attore, lago
Х proprio: quando si riferisce a una sola e particolare unità di una specie, distinguendola da tutte le altre
Es. Mario, Roma, Rossi, Sordi, Maggiore
Х collettivo: quando indica (al singolare) un insieme di unità della stessa specie
Es. branco, stuolo, folla, gregge, mandria, serie
Х individuale: quando indica un esemplare singolo di esseri animati o inanimati. Per indicarne più di uno si usa il plurale1
Es. bambino, cane, pecora, idea, montagna
(1) Sono individuali la quasi totalità dei nomi, esclusi, appunto, quelli collettivi.
secondo la FORMA
Х primitivo: quando non deriva da nessun'altra parola, ma è formato solo dalla radice e dalla desinenza
Es. libro, cane, legno, carta, banca
Х derivato: quando è formato da un nome primitivo con l'aggiunta di un prefisso o di un suffisso
Es. libraio, canile, falegname, cartiera, banchiere
Х alterato: quando l'aggiunta di un suffisso modifica in parte il significato originario.
Può essere:
- accrescitivo: casona, ragazzone, librone
- diminutivo: casina, ragazzino, librino
- vezzeggiativo: casetta, ragazzetto, libretto
- dispregiativo: casaccio, ragazzaccio, libraccio
Х composto: quando è formato dall'unione di due parole
Es. cassaforte, francobollo, saliscendi, sottopassaggio
secondo il GENERE
Х maschile: quando persone o animali sono di sesso maschile. Per le cose una regola non c'è1
Es. ragazzo, Franco, gatto, albero, libro
(1) Per quanto riguarda il genere dei nomi vi sono tante di quelle regole, particolarità
ed eccezioni che è preferibile affidarsi alla pratica e all'uso di un dizionario piuttosto
che ricorrere alla relativa, complicatissima casistica.
Х femminile: quando persone o animali sono di sesso femminile. Per le cose una regola non c'è2
Es. ragazza, Franca, gatta, porta, finestra
(2) Vedi nota precedente.
Inoltre il nome può essere:
Х di genere mobile: quando per il maschile e per il femminile ha la stessa radice, ma muta desinenza o presenta altre modifiche (vedi La formazione del femminile nei nomi mobili).
Es. ragazzo, gatto, maestro, attore, principe
ragazza, gatta, maestra, attrice, principessa
Х di genere comune: quando ha una sola forma sia per il maschile che per il femminile; in questo caso è l'articolo che ne fa distinguere il genere
Es. custode, nipote, cantante, giornalista (il/la)
Х di genere promiscuo: quando ha una sola forma con la quale indica sia il maschio che la femmina. Si tratta per lo più, ma non solo, di nomi di animali.
Per precisare il genere maschile o femminile del nome occorre farlo seguire dalla parola maschio o femmina, oppure farlo precedere da il maschio del..., la femmina del ...3
Es. volpe, tonno, tigre, mosca, balena, delfino
la volpe maschio - il maschio della volpe
la volpe femmina - la femmina della volpe
(3) Sono promiscui anche nomi come persona e vittima. Per loro, però, non si
usa l'aggiunta maschio o femmina.
Х indipendente nei due generi: quando ha una forma per il maschile e una per il femminile, del tutto diverse fra loro
Es. uomo - donna, babbo - mamma, bue - mucca, maschio - femmina, fuco - ape, fratello - sorella, celibe - nubile
secondo il NUMERO
Х singolare: quando indica una sola unità
Es. casa, fiume, monte, tavolo
Х plurale: quando indica più unità
Es. case, fiumi, monti, tavola
Inoltre può essere:
Х variabile: quando al plurale modifica la desinenza
Es. porto - porti, giacca - giacche, busta - buste
Х invariabile: quando ha la stessa forma sia per il singolare che per il plurale; è l'articolo a indicarci il numero
Es. città, auto, moto, virtù, cinema, re, parentesi
Х difettivo: quando manca del singolare o del plurale
Es. latte, sangue, grano, miele, fame, sete, pietà; viveri, spinaci, bronchi, nozze, posteri, ferie, pantaloni
Х sovrabbondante: quando ha più forme di singolare e/o di plurale1
Es. destriero/e, forestiero/e, nocchiero/e, sparviero/e,
bracci/ia, cigli/ia, diti/a, budelli/a, calcagni/a, ginocchi/ia,
orecchio/a (orecchi/ie), strofa/e (strofe/i)
(1) Spesso a forme differenti corrispondono anche significati diversi. Per esempio i
cigli sono i bordi di una strada o di un fosso, le ciglia
sono quelle degli occhi.