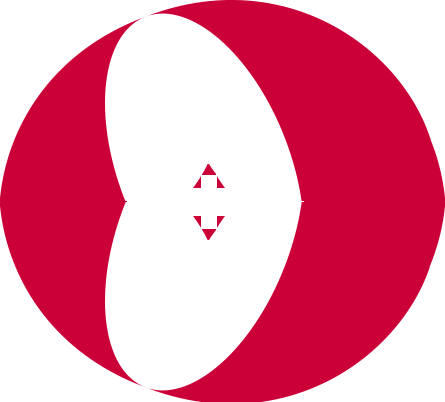ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ
| Alberto Moravia - Il conformista PROLOGO |
| CAPITOLO SECONDO Durante l’estate, al mare, il terrore della fatalità espressa cosi semplicemente dalla cuoca : « si comincia con un gatto e poi si ammazza un uomo », pian piano svanì dall’animo di Marcello. Egli pensava ancora spesso a quella specie di meccanismo imperscrutabile e spietato in cui per alcuni giorni pareva che si fosse impigliata la sua vita; ma con sempre minore spavento, piuttosto come a un segnale d’allarme che alla condanna senza appelli che per qualche tempo aveva temuto. I giorni passavano, lieti, ardenti di sole, inebriati di salsedine, varii di svaghi e di scoperte; e a Marcello, ogni giorno che passava, pareva di conseguire non sapeva che vittoria non tanto contro se stesso che non aveva mai sentito colpevole in maniera volontaria e diretta, quanto contro la forza oscura, malefica, astuta ed estranea, tutta colorata delle tinte brune della fatalità e della disgrazia, che l’aveva portato, quasi suo malgrado, dallo sterminio dei fiori alla strage delle lucertole e da questa al tentativo di uccidere Roberto. Questa forza, la sentiva sempre presente e minacciosa seppure non più incombente; ma, come avviene talvolta negli incubi quando, atterriti dalla presenza di un mostro, si pensa di blandirlo fingendo di dormire mentre in realtà è tutto un sogno che si fa dormendo; gli pareva che non potendo allontanare definitivamente la minaccia di quella forza, gli convenisse addormentarla, per così dire, fingendo un oblio spensierato che era ancora lontano dall’aver raggiunto. Fu quella una delle estati più sfrenate se non più felici di Marcello e certamente l’ultima della sua vita in cui fu bambino senza alcun disgusto della puerizia e alcun desiderio di uscirne. In parte quest’abbandono era dovuto alla naturale inclinazione dell’età; ma in parte anche alla volontà di uscire a tutti i costi dal cerchio maledetto dei presagi e delle fatalità. Marcello non se ne rendeva conto, ma l’impulso che lo spingeva a gettarsi nell’acqua del mare dieci volte in una mattina; a gareggiare in turbolenza coi più turbolenti compagni di giochi; a remare per ore sul mare infuocato; a fare, insomma, con una specie di zelo eccessivo, tutte le cose che si fanno sulle spiagge; era pur sempre lo stesso che gli aveva fatto ricercare la complicità di Roberto dopo la strage delle lucertole e la punizione dei genitori dopo la morte del gatto: un desiderio di normalità; una volontà di adeguazione ad una regola riconosciuta e generale; una voglia di essere simile a tutti gli altri dal momento che essere diverso voleva dire essere colpevole. Ma il carattere volontario e artificioso di questa sua condotta si tradiva ogni tanto nel ricordo improvviso e doloroso del gatto morto disteso fra gli iris bianchi e violetti, nel giardino di Roberto. Quel ricordo lo spaventava come spaventa il debitore il ricordo della propria firma apposta in fondo al documento che comprova il suo debito. Gli pareva, con quella morte, di aver preso un impegno oscuro e terribile al quale presto o tardi non avrebbe potuto sottrarsi, anche se si fosse nascosto sotto terra oppure avesse varcato gli oceani per far perdere le proprie tracce. In quei momenti si consolava pensando che erano passati un mese, due mesi, tre mesi; che presto sarebbe passato un anno, due anni, tre anni; e che, insomma, quel che più importava era non svegliare il mostro e far trascorrere il tempo. Del resto questi soprassalti di sconforto e di paura erano rari e verso la fine dell’estate cessarono del tutto. Come Marcello tornò a Roma, dell’episodio del gatto e di quelli che l’avevano preceduto, non gli restava ormai che una diafana, quasi evanescente rimembranza. Come di una esperienza che egli aveva forse vissuto ma in un’altra vita con la quale, appunto, non aveva altri rapporti che di ricordo irresponsabile e senza conseguenze. All’oblio, poi, contribuì anche, una volta tornato in città, l’eccitazione dell’ingresso a scuola. Marcello aveva sin’allora studiato in casa e quello era il suo primo anno di scuola pubblica. La novità dei compagni, dei professori, delle aule, degli orari, novità in cui traluceva, pur nella varietà d’aspetti, un’idea di ordine, di disciplina e di occupazione in comune, piacque assai a Marcello dopo il disordine, la mancanza di regole e la solitudine di casa sua. Era un po’ il collegio da lui sognato, quel giorno, a tavola, ma senza costrizioni né servitù, soltanto coi suoi aspetti piacevoli e senza quelli spiacevoli che lo facevano rassomigliare ad una prigione. Marcello si accorse ben presto che un gusto profondo lo portava alla vita scolastica. Gli piaceva, alla mattina, alzarsi a tempo di orologio, lavarsi e vestirsi in fretta, chiudere, ben stretto e nitido, il suo pacco di libri e di quaderni nell’incerato legato con gli elastici e affrettarsi per le strade verso la scuola. Gli piaceva irrompere con la folla dei compagni nel vecchio ginnasio, correre su per i sudici scaloni, per i corridoi squallidi e sonori e poi smorzare la foga della corsa nell’aula, tra i banchi allineati, davanti la cattedra vuota. Gli piaceva soprattutto il rituale delle lezioni: l’ingresso del professore; l’appello; le interrogazioni; l'emulazione con i compagni per rispondere alle domande; le vittorie e le sconfitte di questa emulazione; il tono pacato, impersonale, della voce dell’insegnante; la disposizione stessa, cosi eloquente, dell’aula, loro in fila accomunati dallo stesso bisogno di imparare, davanti il professore che insegnava. Marcello era, però, un mediocre scolaro e, per certe materie, addirittura uno degli ultimi. Ciò che amava a scuola non era tanto lo studio quanto un modo tutto nuovo di vita, più conforme ai suoi gusti di quello tenuto sinora. Ancora una volta era la normalità che l’attraeva; e tanto più in quanto gli si rivelava non casuale né affidata alle preferenze e alle inclinazioni naturali dell’animo bensì prestabilita, imparziale, indifferente ai gusti individuali, limitata e sorretta da regole indiscutibili e tutte rivolte ad un fine unico. Ma la sua inesperienza e il suo candore lo rendevano goffo e incerto di fronte alle altre regole, taciute eppure esistenti, che riguardavano i rapporti dei ragazzi tra di loro, fuori della disciplina scolastica. Era anche questo un aspetto della nuova normalità, ma più difficile a padroneggiare. Ne ebbe la sensazione la prima volta che fu chiamato alla cattedra per mostrare il compito scritto. Poiché il professore gli ebbe preso di mano il quaderno e, posandolo sulla cattedra, davanti a sé, si accinse a leggerlo, Marcello avvezzo ai rapporti affettuosi e familiari con le maestre che sin allora lo avevano istruito a casa, invece di starsene ritto in disparte sul palco aspettando il responso, molto naturalmente mise un braccio intorno le spalle dell’insegnante e chinò il viso accanto a quello di lui per seguire con lui la lettura del compito. Il professore si limitò, senza mostrare alcuna meraviglia, a togliere la mano che Marcello gli posava sulla spalla e a liberarsi del braccio; ma tutta la scolaresca ruppe in una risata clamorosa in cui parve a Marcello di avvertire una disapprovazione diversa da quella del professore, molto meno indulgente e comprensiva. Con quel gesto ingenuo, non potè fare a meno di riflettere più tardi, appena gli riuscì di sormontare il disagio della vergogna, egli aveva mancato insieme a due norme diverse, quella scolastica che lo voleva disciplinato e rispettoso del professore e quella dei ragazzi che lo voleva malizioso e dissimulato negli affetti. E, ciò che era ancor più singolare, queste due norme non si contraddicevano anzi si completavano, in maniera misteriosa. Ma, come capi subito, se era abbastanza facile diventare in breve tempo uno scolaro efficiente, molto più difficile era diventare un compagno scaltrito e disinvolto. A questa seconda trasformazione, si opponevano la sua inesperienza, le sue abitudini familiari e perfino il suo aspetto fisico. Marcello aveva ereditato da sua madre una perfezione di tratti quasi leziosa nella sua regolarità e dolcezza. Aveva un viso tondo, dalle guance brune e delicate, il naso piccolo, la bocca sinuosa, dall’espressione capricciosa e imbronciata, il mento rilevato e sotto la frangia dei capelli castani che gli ricopriva quasi per intero la fronte, occhi tra grigi e azzurri, di espressione un po’ fosca sebbene innocente e carezzevole. Era quasi un viso di fanciulla; ma i ragazzi, cosi rozzi, non se ne sarebbero forse accorti se la dolcezza e bellezza del viso non fossero state confermate da alcuni caratteri addirittura femminili cosi da far dubitare che Marcello non fosse davvero una bambina vestita da maschio: una facilità insolita di arrossire, un’inclinazione irresistibile a esprimere la tenerezza dell’animo con gesti carezzevoli, un desiderio di piacere spinto fino alla servilità e alla civetteria. Questi tratti erano nativi in Marcello epperò inconsapevoli; quando si rese conto che lo rendevano ridicolo agli occhi dei ragazzi, era ormai troppo tardi: anche se avesse potuto controllarli, se non sopprimerli, la sua riputazione di femminuccia in calzoni era ormai stabilita. Lo prendevano in giro in una maniera quasi automatica, come se il suo carattere femminile fosse ormai fuori discussione. Ora gli chiedevano con finta serietà come mai non sedesse nei banchi delle ragazze e che idea gli era venuta di cambiare la gonna coi calzoni; ora come passasse il tempo a casa, se ricamando oppure giocando con le bambole; ora perché non avesse i buchi ai lobi delle orecchie per infilarci gli orecchini. Talvolta gli facevano trovare sotto il banco una pezzuola con un ago e un gomitolo, chiara allusione al genere di lavoro al quale avrebbe dovuto dedicarsi; talora uno scatolino di cipria; un mattino, addirittura, un reggipetto rosa che uno dei ragazzi aveva rubato alla sorella maggiore. Fin da principio, poi, trasformando il suo nome in un diminutivo femminile, l’avevano chiamato Marcellina. Egli provava di fronte a queste canzonature un sentimento misto di stizza e di non sapeva che lusingato compiacimento, come se una parte di lui, in fondo, non fosse stata troppo scontenta; tuttavia non avrebbe saputo dire se questo compiacimento fosse dovuto alla qualità della canzonatura oppure al fatto che, sia pure per beffarlo, i compagni si occupavano di lui. Ma una mattina che, al solito, gli sussurravano dietro le spalle: «Marcellina... Marcellina... è vero che hai le mutandine di donna? », egli si alzò e, richiesto con il braccio alzato di parlare, si lagnò con voce forte, nel silenzio improvviso della classe, di esser chiamato con un soprannome femminile. Il professore, un omaccione barbuto, lo ascoltò, sorridendo tra i peli della barba grigia, e poi disse: «Ti chiamano con un soprannome di donna... e qual’è? » «Marcellina», disse Marcello. «E ti dispiace?» «Si... perché sono un uomo». « Vieni qui », disse il professore. Marcello ubbidì e venne a mettersi accanto alla cattedra. « Ora », continuò piacevolmente il professore, « mostra i tuoi muscoli alla classe». Marcello, ubbidiente, piegò il braccio gonfiando i muscoli. Il professore si sporse dalla cattedra, gli toccò il braccio, scosse il capo in segno di ironica approvazione e poi, rivolto alla scolaresca, disse : « Come potete vedere, Clerici è un ragazzo forte... ed è pronto a dimostrare di essere un uomo e non una donna... chi vuole sfidarlo? » Seguì un lungo silenzio. Il professore girò lo sguardo sulla classe e quindi concluse: «Nessuno... allora è segno che avete paura di lui... dunque smettete di chiamarlo Marcellina». Tutta la scolaresca scoppiò in una risata. Rosso in viso, Marcello tornò al suo posto. Ma da quel giorno, invece di cessare, le canzonature raddoppiarono, inasprite forse dal fatto che Marcello, come gli dissero, aveva fatto la spia, mancando in tal modo alla tacita legge di omertà che legava tra di loro i ragazzi. Marcello si rendeva conto che, per far cessare queste canzonature, doveva dimostrare ai compagni di non essere così effeminato come sembrava; ma intuiva che per una simile dimostrazione non bastava, come gli aveva suggerito il professore, ostentare i muscoli del braccio. Ci voleva qualche cosa di più insolito, atto a colpire le immaginazioni e a suscitare ammirazione. Che cosa? Non avrebbe saputo dirlo con precisione, ma, in senso generale, un’azione o un oggetto che suggerissero idee di forza, di virilità, se non addirittura di brutalità. Aveva notato che i compagni ammiravano assai certo Avanzini perché possedeva un paio di guantoni di cuoio, da boxe. Quei guantoni, Avanzini, un biondino mingherlino, più piccolo e meno forte di lui, non sapeva neppure adoperarli; tuttavia gli avevano fruttato una considerazione particolare. Analoga ammirazione andava pure a certo Pugliese perché conosceva o meglio pretendeva di conoscere un colpo di lotta giapponese, infallibile, a suo dire, per mettere a terra l’avversario. Alla prova, a dire il vero, Pugliese non aveva mai saputo applicarlo; questo però non impediva che i ragazzi lo rispettassero allo stesso modo di Avanzini. Marcello capiva che doveva quanto prima ostentare il possesso di un oggetto come i guantoni oppure escogitare qualche prodezza del genere della lotta giapponese; ma capiva pure di non essere cosi leggero e cosi dilettantesco come i suoi compagni; di appartenere, invece, gli piacesse o no, alla razza di coloro che prendono sul serio la vita e i suoi impegni ; e che, al posto di Avanzini, avrebbe rotto il naso ai suoi avversari e, al posto di Pugliese, gli avrebbe fiaccato il collo. Questa sua incapacità di retorica e di superficialità gli ispirava un’oscura diffidenza verso se stesso; cosi, mentre desiderava fornire ai compagni la prova di forza che sembravano domandargli in cambio della loro considerazione, al tempo stesso ne era oscuramente spaventato. Uno di quei giorni, si accorse che alcuni dei ragazzi, tra i più accaniti di solito a canzonarlo, confabulavano tra di loro; e gli parve di capire dai loro sguardi che tramassero qualche nuovo scherzo ai suoi danni. Tuttavia, l’ora della lezione trascorse senza incidenti, sebbene le occhiate e i bisbigli lo confermassero nel suo sospetto. Venne il segnale dell’uscita e Marcello, senza guardarsi attorno, si incamminò verso casa. Si era ai primi giorni di novembre, con un’aria tempestosa e mite, in cui parevano mescolarsi gli ultimi calori e profumi dell’estate ormai defunta con i primi, ancora incerti rigori autunnali. Marcello si sentiva oscuramente eccitato da questa atmosfera di sgombero e di strage naturale in cui avvertiva una smania di distruzione e di morte molto simile a quella che, mesi addietro, gli aveva fatto decapitare i fiori e uccidere le lucertole. L’estate era stata una stagione immobile, perfetta, piena, sotto un cielo sereno, con alberi carichi di foglie e rami gremiti di uccelli. Adesso, egli vedeva con delizia il vento autunnale lacerare e distruggere quella perfezione, quella pienezza, quell’immobilità spingendo scure nubi stracciate nel cielo, strappando le foglie agli alberi e mulinandole a terra, cacciando via gli uccelli che, infatti, si scorgevano migrare tra le foglie e le nubi, in neri stuoli ordinati. Ad una svolta, si accorse che un gruppo di cinque compagni lo seguiva; e che lo seguisse non era dubbio perché due di loro abitavano nella direzione opposta; ma, immerso nelle sue sensazioni autunnali, non ci fece caso. Adesso, aveva fretta di raggiungere un grande viale piantato di platani dal quale, per una via traversa, si giungeva a casa sua. Sapeva che le foglie morte in quel viale si ammucchiavano a migliaia sopra i marciapiedi, gialle e sonore; e pregustava il piacere di trascinare i piedi nei mucchi, scompigliandoli e facendoli frusciare. Intanto, quasi per gioco, tentava di far perder le tracce ai suoi inseguitori, ora entrando in un portone, ora confondendosi con la folla. Ma i cinque, come si accorse ben presto, dopo un momento di incertezza, sempre lo ritrovavano. Ormai il viale era vicino; e Marcello si vergognava di farsi vedere in atto di divertirsi con le foglie morte. Decise allora di affrontarli, e, voltandosi improvvisamente, domandò : « Perché mi seguite ? » Uno dei cinque, un biondino dalla faccia aguzza e dalla testa rapata, rispose prontamente: «Non ti seguiamo, la strada è di tutti, no?» Marcello non disse nulla e riprese il cammino. Ecco il viale, tra le due file di platani giganteschi e spogli, con le case piene di finestre allineate dietro i platani, ecco le foglie morte, gialle come l’oro, sparse sull’asfalto nero e ammucchiate nei fossati. I cinque, adesso, non si vedevano più, forse avevano rinunziato a seguirlo e lui era solo per il largo viale dai marciapiedi deserti. Senza fretta, entrò coi piedi tra il fogliame sparso sul lastrico e cominciò a camminare piano godendo a sprofondare le gambe fino al ginocchio in quella mobile e leggera massa di spoglie sonore. Ma come si chinava ad afferrare una manciata di foglie con l’intenzione di gettarle per aria, udì di nuovo le voci canzonatorie: « Marcellina... Marcellina... mostra la mutandina ». Allora gli venne ad un tratto una voglia di battersi, quasi piacevole, che gli accese il viso di eccitazione pugnace. Si rialzò e andò con decisione incontro ai suoi persecutori dicendo: « Volete andarvene, si o no? » Invece di rispondere, gli si gettarono tutti e cinque addosso. Marcello aveva pensato di fare un po’ come gli Orazi e i Curiazi, secondo l’aneddoto dei libri di storia: prenderli uno per uno, correndo qua e là, e assestare a ciascuno qualche brutto colpo, in modo da convincerli ad abbandonare la loro impresa. Ma si accorse subito che questo piano era impossibile: previdentemente i cinque gli si erano stretti tutti insieme addosso e ora lo tenevano, uno per le braccia, un altro per le gambe e due a mezzo corpo. Il quinto, come si accorse, aveva intanto aperto in fretta un involto e ora gli si avvicinava, guardingo, tenendo sospesa con le mani una gonnella di bambina, di cotone turchino. Tutti ridevano, adesso, pur mantenendolo fermo; e quello della gonnella disse: « Su Marcellina... lasciati fare... ti mettiamo la gonnella e poi ti lasciamo andare dalla mamma ». Era, insomma, proprio il genere di scherzo che Marcello aveva presentito, suggerito, al solito, dal suo aspetto non abbastanza maschile. Rosso in viso, furioso, prese a dibattersi con estrema violenza; ma i cinque erano più forti e, sebbene gli riuscisse di graffiare il viso a uno e di assestare un pugno nello stomaco ad un altro, senti che, gradualmente, i propri movimenti venivano ridotti. Finalmente, mentre gemeva: «Lasciatemi... cretini... lasciatemi », un grido di trionfo fuggi dalle bocche dei suoi persecutori : la gonnella calava sulla sua testa e ormai le sue proteste si perdevano dentro quella specie di sacco. Egli si dibattè ancora, ma invano. Abilmente i ragazzi gli fecero discendere la gonna fino alla vita; e poi senti che gliela legavano con un nodo sul dorso. Allora, mentre essi gridavano: « Stringi... dagli... più stretto», udì una voce tranquilla domandare più in tono di curiosità che di rimprovero: « Ma si può sapere cosa fate? » Subito i cinque lo lasciarono, fuggendo via; e lui si ritrovò solo, tutto scarmigliato e ansimante, la gonnella legata alla vita. Levò gli occhi e vide ritto davanti a lui l’uomo che aveva parlato. Vestito di una uniforme grigio scura, il colletto stretto sotto la gola, pallido, scarno, gli occhi infossati, il naso grande e triste, la bocca sdegnosa e i capelli tagliati a spazzola, dava a tutta prima un’impressione di austerità quasi eccessiva. Ma poi, ad un secondo sguardo, come notò Marcello, si rivelavano alcuni tratti che nulla avevano di austero, al contrario: lo sguardo ansioso, ardente degli occhi; un che di molle e di quasi sfatto nella bocca; la generale insicurezza dell’atteggiamento. Egli si chinò, raccolse i libri che Marcello, dibattendosi, aveva lasciato cadere in terra e disse, porgendoglieli: « Ma che ti volevano fare? » Aveva una voce anch’essa severa, come il viso, ma insieme non priva di una sua strangolata dolcezza. Marcello rispose irritato: «Mi fanno sempre degli scherzi... sono dei veri stupidi». Intanto cercava di slegare sul dorso la cintura della gonna. « Aspetta » disse l’uomo chinandosi e sciogliendo il nodo. La gonna cadde in terra e Marcello ne usci calpestandola e poi lanciandola con un calcio sul mucchio delle foglie morte. L’uomo domandò, con una specie di timidezza : « Non stavi forse andando a casa tua? » « Si », rispose Marcello levando gli occhi verso di lui. « Ebbene » disse l’uomo « ti ci porto io, in macchina »; e indicò, a non grande distanza, un’automobile ferma presso il marciapiede. Marcello la guardò: era una macchina di un tipo che non conosceva, forse straniera, lunga, nera, di foggia antiquata. Stranamente, gli venne fatto di pensare che quella macchina ferma, li a due passi da loro, denotasse una premeditazione nei casuali approcci dell’uomo. Esitò, prima di rispondere; l’uomo insistette: «Vieni, su... prima di portarti a casa ti faccio fare un bel giro... ti va ? » Marcello avrebbe voluto rifiutare o meglio senti che avrebbe dovuto. Ma non ne ebbe il tempo: l’uomo gli aveva già tolto di mano il pacco dei libri dicendo: «Te lo porto io»; già si avviava verso la automobile. Lo segui un po’ stupito dalla propria docilità, ma non scontento. L’uomo apri lo sportello, fece salire Marcello nel posto accanto al suo, e scaraventò i libri sul sedile posteriore. Poi sedette al volante, chiuse lo sportello, infilò i guanti e mise in moto la macchina. L’automobile prese a correre senza fretta, maestosamente, con un ronzio sommesso, per il lungo viale alberato. Era proprio una macchina di vecchio tipo, come pensò Marcello, ma tenuta in perfetta efficienza, amorosamente lucidata, con tutti gli ottoni e le nichelature sfavillanti. Adesso l’uomo, pur tenendo con una mano il volante, con l’altra aveva preso un berretto a visiera e se l’aggiustava sul capo. Il berretto confermava il suo aspetto severo, vi aggiungeva un’aria quasi militare. Marcello domandò impacciato : « È sua la macchina ? » « Dammi del tu », disse l’uomo senza voltarsi e andando con la mano destra a premere la pompa di una tromba dal suono grave e anch’esso antiquato come la macchina. «Non è mia... è di chi mi paga... io sono l’autista». Marcello non disse nulla. L’uomo, sempre stando di profilo e continuando a condurre la macchina con una precisione distaccata ed elegante, soggiunse : « Ti dispiace che io non sia il padrone ? Ti vergogni ? » Marcello protestò con vivacità : « No, perche ? » L’uomo ebbe un leggero sorriso di compiacimento e accelerò l’andatura. Disse : « Adesso andiamo un po’ in collina... sul Monte Mario... ti va? » « Non ci sono mai stato », rispose Marcello. L’uomo disse: «È bello, si vede tutta la città...» Tacque un momento e poi soggiunse, con dolcezza: « Come ti chiami ? » « Marcello ». « Già è vero », disse l’uomo come parlando a se stesso, « ti chiamavano Marcellina, quei tuoi compagni... io mi chiamo Pasquale ». |