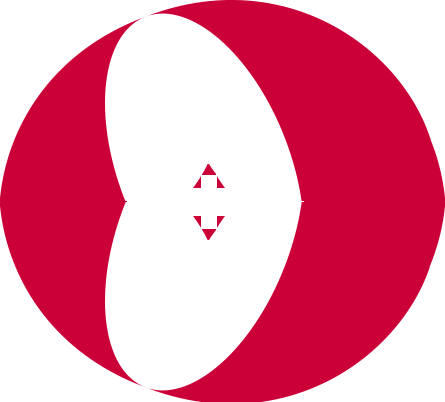ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ
| Alberto Moravia - Il conformista PROLOGO / CAPITOLO PRIMO |
| Il giorno dopo il tempo era caldo a rannuvolato. Marcello, dopo aver
mangiato in silenzio tra i due genitori silenziosi, scivolò di soppiatto
giù dalla seggiola e, per la portafinestra, usci nel giardino. Come il
solito, la digestione provocava in lui un torpido malessere tutto
mischiato di turgida e riflessiva sensualità. Camminando piano, quasi in
punta di piedi, sulla ghiaia scricchiolante, all’ombra degli alberi
fervida di insetti, andò fino al cancello e guardò di fuori. Gli apparve
la strada cosi nota, in leggera pendenza, fiancheggiata da due file di
alberi del pepe, di un verde piumoso e quasi lattescente, deserta a
quell’ora e stranamente buia per via delle basse nuvole nere che
ingombravano il cielo. Dirimpetto, si intravvedevano altri cancelli,
altri giardini, altre ville simili alla sua. Dopo aver osservato con
attenzione la strada, Marcello si staccò dal cancello, trasse di tasca
la fionda e si chinò verso terra. Tra la ghiaia minuta, erano frammisti
alcuni ciottoli bianchi più grossi. Marcello ne prese uno della
grandezza di una noce, lo inserì nel disco di cuoio della fionda e prese
a passeggiare lungo il muro che separava il suo giardino da quello di
Roberto. La sua idea, o meglio il suo sentimento, era che egli si
trovava in stato di guerra con Roberto e che doveva sorvegliare con la
massima attenzione l’edera che ricopriva il muro di cinta e, al minimo
movimento, far fuoco, ossia scagliare il sasso che stringeva nella
fionda. Era un gioco in cui esprimeva insieme il rancore contro Roberto
che non aveva voluto essergli complice nella strage delle lucertole e
l’istinto belluino e crudele che l’aveva spinto alla strage medesima.
Naturalmente Marcello sapeva benissimo che Roberto, solito a dormire a
quell’ora, non lo spiava da dietro il fogliame dell’edera; e tuttavia,
pur sapendolo, agiva con serietà e conseguenza, come se fosse stato
sicuro che invece Roberto ci fosse. L’edera, vecchia e gigantesca,
saliva fino alle punte delle picche della cancellata, e le foglie,
sovrapposte le une alle altre, grandi, nere, polverose, simili a volanti
di trina su un petto tranquillo di donna, stavano ferme e flosce
nell’aria pesante e senza vento. Un paio di volte, gli parve che un
leggerissimo fremito facesse palpitare il fogliame o meglio inventò a se
stesso di aver veduto questo fremito e tosto, con soddisfazione intensa,
scagliò il sasso nel fitto dell’edera. Subito dopo il colpo, si chinava in fretta, raccoglieva un altro sasso e si rimetteva in posizione di combattimento, le gambe larghe, le braccia stese in avanti, la fionda pronta a scattare: non si poteva mai sapere, Roberto poteva essere dietro le foglie, in atto di prender la mira contro di lui, con il vantaggio di esser nascosto, mentre lui, invece, era compietamente allo scoperto. Cosi, in questo gioco, giunse in fondo al giardino, là dove aveva ritagliato lo sportello nel fogliame dell’edera. Qui si fermò, guardando con attenzione al muro di cinta. Nella sua fantasia, la casa era un castello, la cancellata nascosta dal rampicante le mura fortificate, e il pertugio una breccia pericolosa e facilmente valicabile. Allora, improvvisamente e questa volta senza possibilità di dubbio, vide le foglie muoversi da destra a sinistra, tremando e oscillando. Sì, ne era certo, le foglie si muovevano e qualcuno doveva pur farle muovere. Tutto in un sol momento, pensò che Roberto non c’era, che era un gioco e che, visto che era un gioco, lui poteva tirare il sasso; e al tempo stesso che Roberto c’era e lui non doveva tirare il sasso se non voleva ammazzarlo. Poi, con subitanea e spensierata decisione, tese gli elastici e scagliò il sasso nel folto delle foglie. Non contento, si chinò, febbrilmente incastrò un altro sasso nella fionda, lo tirò, ne prese un terzo, tirò anche quello. Ormai aveva messo da parte scrupoli e timori e non gli importava più che Roberto ci fosse o non ci fosse: provava soltanto un senso di eccitazione ilare e bellicoso. Finalmente, ansimante, dopo aver ben bene sforacchiato il fogliame, lasciò cadere la fionda in terra e si inerpicò fino al muro di cinta. Come aveva preveduto e sperato, Roberto non c’era. Ma le sbarre della cancellata erano molto larghe e permettevano di sporgere il capo nel giardino attiguo. Punto da non sapeva che curiosità, si affacciò e guardò in basso. Dalla parte del giardino di Roberto, non c’era rampicante, bensì un’aiuola coltivata a iris che correva tra il muro e il vialetto ghiaiate. Allora, proprio sotto i suoi occhi, tra il muro e la fila degli iris bianchi e violetti, disteso su un fianco, Marcello vide un grosso gatto grigio. Un terrore insensato gli tagliò il respiro poiché notò la posizione innaturale della bestia: coricata di lato, con le zampe allungate e rilasciate, il muso abbandonato sul terriccio. Il pelo, folto e di un grigio azzurrognolo, appariva leggermente irto e arruffato e insieme inerte, come le piume di certi uccelli morti che aveva osservato tempo ad dietro sul tavolo di marmo della cucina. Ora il terrore cresceva: balzò a terra, sfilò da un roseto la canna di sostegno, tornò ad inerpicarsi, e, sporgendo il braccio tra le sbarre, si ingegnò di pungere il fianco al gatto con la punta terrosa della canna. Ma il gatto non si mosse. Tutto ad un tratto gli iris dagli alti gambi verdi, dalle corolle bianche e violette inclinate intorno il grigio corpo immobile, gli parvero mortuarii, come tanti fiori disposti da una mano pietosa intorno un cadavere. Gettò via la canna e, senza curarsi di rimettere a posto l’edera, saltò a terra. Si sentiva in preda a diversi terrori e il suo primo impulso fu di correre a chiudersi in un armadio, in un ripostiglio, dovunque, insomma, ci fosse buio e clausura, per sfuggire a se stesso. Provava terrore prima di tutto per avere ucciso il gatto e poi, forse in misura maggiore, per avere annunziato quest’uccisione alla madre, la sera prima: segno indubbio che, in un modo misterioso e fatale, era predestinato a compiere atti di crudeltà e di morte. Ma il terrore che destavano in lui la morte del gatto e la premonizione significativa di questa morte, era di gran lunga superato dal terrore che gli ispirava l’idea che uccidendo il gatto, in realtà, aveva avuto intenzione di uccidere Roberto. Soltanto il caso aveva voluto che il gatto fosse morto in luogo dell’amico. Un caso, però, non privo di senso; che non si poteva negare che ci fosse stata progressione dai fiori alle lucertole, dalle lucertole al gatto e dal gatto all’omicidio di Roberto pensato e voluto seppure non eseguito, ma tuttora eseguibile e, forse, inevitabile. Cosi, egli era un anormale, non poteva fare a meno di pensare, o meglio di sentire, con una viva, fisica consapevolezza di questa anormalità, un anormale segnato da un destino solitario e minaccioso e ormai avviato per una strada sanguigna sulla quale nessuna forza umana avrebbe potuto fermarlo. Tra questi pensieri si aggirava freneticamente nel breve spazio tra la casa e il cancello levando ogni tanto gli occhi alle finestre del villino quasi con desiderio di vedervi apparire la figura della sua frivola e stordita madre: ma ormai ella non poteva più far nulla per lui, se pure era mai stata capace di fare qualche cosa. Quindi, con subitanea speranza, corse di nuovo in fondo al giardino, si arrampicò fino al muro e si affacciò tra le sbarre della cancellata. Quasi si illudeva di ritrovare vuoto il luogo dove prima aveva veduto il gatto esanime. Invece il gatto non se ne era andato, era sempre là, grigio e immobile nella corona funeralesca degli iris bianchi e violetti. E la morte era accusata, con un senso macabro di carogna in putrefazione, da una nera striscia di formiche che partendo dal viale risalivano l’aiuola fino al muso, anzi agli occhi della bestia. Guardava e, tutto ad un tratto, quasi per sovraimpressione, gli parve di vedere in luogo del gatto, Roberto, anche lui disteso tra gli iris, anche lui esanime, con le formiche che andavano e venivano dagli occhi spenti e dalla bocca semiaperta. Con un brivido di raccapriccio, si tolse da questa orribile contemplazione e saltò giù. Ma questa volta ebbe cura di tirare al suo posto lo sportello di edera. Ché adesso, insieme al rimorso e al terrore di se stesso, affiorava anche la paura di essere scoperto e punito. Tuttavia, mentre le temeva, sentiva che al tempo stesso desiderava questa scoperta e questa punizione; se non altro per essere fermato a tempo sulla china sdrucciolevole in fondo alla quale gli sembrava inevitabile che dovesse aspettarlo l’omicidio. Ma i genitori non l’avevano mai punito, che egli ricordasse; e questo non tanto per un concetto educativo che escludesse la punizione, quanto, come capiva vagamente, per indifferenza. Cosi, alla sofferenza di sospettarsi autore di un delitto e soprattutto capace di commetterne altri più gravi, si aggiungeva quella di non sapere a chi rivolgersi per farsi punire e di ignorare persino quale potesse essere la punizione. Marcello si rendeva conto oscuramente che lo stesso meccanismo che l’aveva spinto a confidare la propria colpa a Roberto nella speranza di sentirsi dire che non era una colpa ma una cosa comune che tutti facevano, adesso gli suggeriva di fare la stessa rivelazione ai genitori nell’opposta speranza di vederli esclamare con indignazione che aveva commesso un crimine orrendo per il quale doveva espiare una pena adeguata. E poco gli importava che nel primo caso l’assoluzione di Roberto l’avrebbe incoraggiato a ripetere l’azione che, nel secondo caso, gli avrebbe, invece, attirato una severa condanna. In realtà, come capiva, in ambedue i casi egli voleva uscire dall’isolamento terrificante dell’anormalità, a tutti i costi e con qualsiasi mezzo. Forse si sarebbe deciso a confessare ai genitori l’uccisione del gatto se, quella stessa sera, a cena, non avesse avuto la sensazione che sapevano già ogni cosa. Come, infatti, si fu seduto a tavola, notò con un senso misto di sgomento e di malcerto sollievo, che il padre e la madre parevano ostili e di cattivo umore. La madre, il viso puerile atteggiato ad un’espressione di esagerata dignità, se ne stava dritta, gli occhi bassi, in un silenzio chiaramente sdegnoso. Di fronte a lei, il padre mostrava per segni diversi ma non meno parlanti, analoghi sentimenti di malumore. Il padre, di molti anni più vecchio della moglie, dava spesso a Marcello la sensazione sconcertante di essere accomunato insieme con sua madre in una stessa aria infantile e soggetta, come se ella non gli fosse stata madre ma sorella. Era magro, con un viso secco e rugoso, raramente illuminato da brevi risate senza gioia, nel quale erano notevoli due tratti legati da un nesso indubbio: lo scintillio inespressivo, quasi minerale delle pupille sporgenti e il guizzo frequente, sotto la pelle tirata della guancia, di non si capiva che nervo frenetico. Forse dai molti anni passati nell'esercito, egli aveva conservato il gusto per i gesti precisi, per gli atteggiamenti controllati. Ma Marcello sapeva che quando suo padre era adirato, precisione e controllo diventavano eccessivi, cangiandosi nel contrario, ossia in una strana violenza contenuta e puntuale, rivolta, si sarebbe detto, a caricare di significato i gesti più semplici. Ora, quella sera, a tavola, Marcello notò subito che il padre sottolineava con forza, quasi a richiamarvi sopra l’attenzione, azioni abituali e di nessuna importanza. Prendeva, per esempio, il bicchiere, beveva un sorso e poi lo rimetteva a posto con un colpo forte sulla tavola; cercava la saliera, ne toglieva un pizzico di sale e poi giù, deponendola, un altro colpo; afferrava il pane, lo spezzava e quindi lo riposava con un terzo colpo. Oppure, come invaso da una subitanea smania di simmetria, si dava a inquadrare, coi soliti colpi, il piatto tra le posate, in modo che coltello, forchetta e cucchiaio si incontrassero ad angolo retto intorno il circolo della scodella. Se Marcello fosse stato meno preoccupato dalla propria colpevolezza, si sarebbe accorto facilmente che questi gesti cosi densi di energia significativa e patetica erano rivolti non già a lui ma a sua madre; la quale, infatti, ad ognuno di quei colpi, si rinsaccava nella propria dignità con certi sospiri di sufficienza e certe alzate di sopracciglia piene di sopportazione. Ma la sua preoccupazione lo accecava, cosi che non dubitò che i genitori sapessero ogni cosa : certamente Roberto, da quel coniglio che era, aveva fatto la spia. Aveva desiderato la punizione, ma adesso, vedendo i genitori cosi corrucciati, gli venne un improvviso ribrezzo della violenza di cui sapeva capace suo padre in simili circostanze. Come le manifestazioni di affetto della madre erano sporadiche, casuali, dettate evidentemente più dal rimorso che dall’amor materno, cosi le severità paterne erano improvvise, ingiustificate, eccessive, suggerite, si sarebbe detto, piuttosto dal desiderio di rimettersi in pari dopo lunghi periodi di distrazione che da una intenzione educativa. Tutto ad un tratto, su una lagnanza della madre o della cuoca, il padre ricordava di aver un figlio, urlava, dava in smanie, lo percuoteva. Soprattutto le percosse spaventavano Marcello perché il padre aveva al mignolo un anello con un castone massiccio che, durante queste scene, non si sa come, si trovava sempre voltato dalla parte della palma, aggiungendo cosi, alla durezza umiliante dello schiaffo, un dolore più penetrante. Marcello sospettava che il padre voltasse apposta in dentro il castone, ma non ne era sicuro. Intimidito, spaventato, incominciò ad architettare in fretta e in furia una bugia plausibile: lui non aveva ucciso il gatto, era stato Roberto, e, infatti, il gatto si trovava nel giardino di Roberto, e come avrebbe fatto lui ad ammazzarlo attraverso l’edera e il muro di cinta? Ma poi, improvvisamente, ricordò che la sera avanti aveva annunziato alla madre l’uccisione del gatto che poi, in effetti, era avvenuta il giorno dopo, e capi che qualsiasi bugia gli era preclusa. Per quanto distratta, sua madre aveva certamente riferito la sua confessione al padre e questi, non meno certamente, aveva stabilito un nesso tra la confessione e le accuse di Roberto; e cosi non c’era alcuna possibilità di smentita. A questo pensiero, passando da l’uno all’altro estremo, con rinnovato impulso desiderò la punizione, purché venisse presto e fosse decisiva. Quale? Ricordò che Roberto, un giorno, aveva parlato di collegi come di luoghi dove i genitori mettevano i figli discoli per punizione, e si sorprese a desiderare vivamente questo genere di pena. Era l'inconsapevole stanchezza della vita familiare disordinata e poco affettuosa che si esprimeva in questo desiderio; non soltanto facendogli vagheggiare ciò che i genitori avrebbero considerato un castigo, ma anche inducendolo a truffare se stesso e il proprio bisogno di questo castigo, con il calcolo quasi furbo che in tal modo avrebbe al tempo stesso calmato il proprio rimorso e migliorato il proprio stato. Questo pensiero gli suggerì subito delle immagini che avrebbero dovuto essere scuoranti e invece gli riuscivano grate: un severo, freddo edificio grigio dai finestroni sbarrati da inferriate; camerate gelide e disadorne con file di letti allineati sotto alti muri bianchi; aule smorte, piene di banchi, con la cattedra in fondo; corridoi nudi, scale buie, porte massicce, cancelli invalicabili: tutto insomma, come in una prigione eppure tutto preferibile alla libertà inconsistente, angosciosa, insostenibile della casa paterna. Persino l’idea di portare un’uniforme di rigatino e di aver la testa rasata, come i collegiali che gli accadeva talvolta di incontrare incolonnati per le strade; perfino quest’idea umiliante e quasi ripugnante gli riusciva grata nella sua presente disperata aspirazione ad un ordine e ad una normalità purchessia. Tra queste fantasticherie non guardava più al padre ma alla tovaglia abbagliante di luce bianca su cui, ogni tanto, si abbattevano gli insetti notturni che dalla finestra spalancata venivano a cozzare contro il paralume della lampada. Poi alzò gli occhi e fece appena in tempo a vedere, proprio dietro suo padre, sul davanzale della finestra, il profilo di un gatto. Ma la bestia, prima che egli avesse potuto distinguerne il colore, saltò giù, attraversò la sala da pranzo e scomparve dalla parte della cucina. Sebbene non ne fosse del tutto sicuro, tuttavia il cuore gli si gonfiò di gioiosa speranza al pensiero che potesse essere il gatto che poche ore prima aveva veduto steso immobile tra gli iris, nel giardino di Roberto. E fu contento di questa speranza, segno che dopo tutto gli premeva più la vita dell’animale che il proprio destino. « Il gatto » esclamò con voce forte. E poi, gettando il tovagliolo sulla tavola e stendendo una gamba fuori della seggiola : « Papà, ho finito, posso alzarmi ? » «Tu stai al tuo posto », disse il padre con voce minacciosa. Marcello, intimidito, arrischiò : « Ma il gatto è vivo... ». « Ti ho già detto di stare al tuo posto » ribadì il padre. Quindi, come se le parole di Marcello avessero infranto anche per lui il lungo silenzio, si voltò verso la moglie dicendo: « Allora, di’ qualche cosa, parla ». « Non ho nulla da dire», ella rispose con ostentata dignità, le palpebre basse, la bocca sdegnosa. Era vestita da sera, con un abito nero scollato; Marcello notò che stringeva tra le dita magre un piccolo fazzoletto che portava frequentemente al naso; con l’altra mano afferrava e lasciava ricadere sulla tavola un pezzo di pane, ma non con le dita, bensì con le punte delle unghie, come un uccello. |