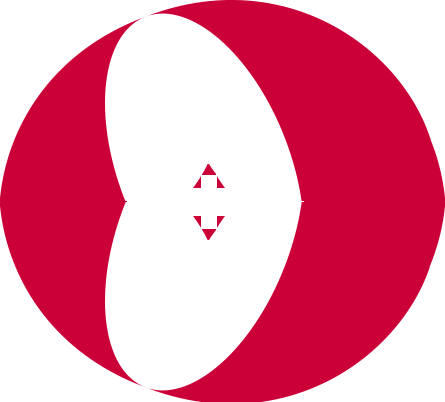ÈÒÀËÜßÍÑÊÈÉ ßÇÛÊ
| Alberto Moravia - Il conformista |
| PROLOGO CAPITOLO PRIMO Nel tempo della sua fanciullezza, Marcello era affascinato dagli oggetti come una gazza. Forse perché, a casa, più per indifferenza che per austerità, i genitori non avevano mai pensato a soddisfare il suo istinto di proprietà; o, forse, perché altri istinti più profondi e ancora oscuri si mascheravano in lui da avidità; egli era continuamente assalito da voglie furiose per gli oggetti più diversi. Una matita con il puntale di gomma, un libro illustrato, una fionda, un regolo, un calamaio portatile di ebanite, qualsiasi nonnulla sollevava il suo animo, prima ad un desiderio intenso e irragionevole della cosa agognata e poi, una volta la cosa entrata in suo possesso, ad uno stupefatto, stregato, insaziabile compiacimento. Marcello aveva in casa una camera tutta per lui dove dormiva e studiava. Qui, tutti gli oggetti sparsi sulla tavola o chiusi nei cassetti, avevano per lui il carattere di cose ancora sacre o appena sconsacrate secondo che il loro acquisto fosse recente o antico. Non erano, insomma, oggetti simili agli altri che si trovavano in casa, bensì frantumi di un’esperienza da farsi o già fatta, tutta carica di passione e di oscurità. Marcello si rendeva conto, a modo suo, di questo carattere singolare della proprietà e, mentre ne traeva un godimento ineffabile, al tempo stesso ne soffriva, come di una colpa che si rinnovava continuamente e non lasciava neppure il tempo di provarne rimorso. Tra tutti gli oggetti, però, quelli che lo attraevano di più, forse perché gli erano proibiti, erano le armi. Non già le armi finte con cui giocano i bambini, i fucili di latta, le rivoltelle a detonazione, i pugnali di legno, bensì le armi vere, nelle quali l’idea della minaccia, del pericolo e della morte non è affidata ad una mera somiglianza di forme, bensì è ragione prima e ultima della loro esistenza. Con la rivoltella dei bambini si giocava alla morte senza alcuna possibilità di provocarla davvero, ma con le rivoltelle dei grandi la morte era non soltanto possibile ma incombente, come una tentazione frenata dalla sola prudenza. Marcello aveva avuto qualche volta tra le mani queste armi vere, un fucile da caccia in campagna, la vecchia rivoltella del padre che costui, un giorno, gli aveva mostrato in un cassetto, e, ogni volta, aveva provato un brivido di comunicazione, come se la sua mano avesse finalmente trovato un naturale prolungamento nell’impugnatura dell’arma. Marcello aveva amici numerosi tra i bambini del quartiere, e ben presto si era accorto che il suo gusto per le armi aveva origini più profonde e oscure delle loro innocenti infatuazioni militari. Essi giocavano ai soldati fingendo spietatezza e ferocia ma in realtà perseguendo il gioco per amore del gioco e scimmiottando quei crudeli atteggiamenti senza alcuna vera partecipazione; in lui, invece, avveniva il contrario: erano la spietatezza e la ferocia che cercavano uno sfogo nel gioco dei soldati e, in mancanza del gioco, in altri passatempi tutti intonati al gusto della distruzione e della morte. In quel tempo Marcello era crudele senza rimorso né vergogna, del tutto naturalmente, perché dalla crudeltà gli venivano i soli piaceri che non gli sembrassero insipidi e questa crudeltà era ancora abbastanza puerile per non destare sospetti in lui stesso o negli altri. Gli accadeva, per esempio, di scendere nel giardino, ad un’ora calda, in quell’inizio d’estate. Era un giardino angusto ma folto nel quale, in gran disordine, crescevano numerose piante e alberi abbandonati da anni al loro naturale rigoglio. Marcello scendeva nel giardino armato di un giunco sottile e flessibile che aveva strappato in soffitta da un vecchio battipanni; e per un poco si aggirava tra le ombre scherzose degli alberi e i raggi ardenti del sole, per i vialetti ghiaiati, osservando le piante. Sentiva che i propri occhi scintillavano, che tutto il corpo gli si apriva ad una sensazione di benessere che pareva confondersi con la generale vitalità del giardino rigoglioso e pieno di luce, e si sentiva felice. Ma di una felicità aggressiva e crudele, quasi vogliosa di misurarsi al paragone dell’infelicità altrui. Come vedeva nel mezzo di un’aiuola un bel cespo di margherite gremito di fiori bianchi e gialli, oppure un tulipano dalla corolla rossa ritta sul gambo verde, oppure ancora una pianta di calle dagli alti fiori bianchi e carnosi, Marcello vibrava un sol colpo col giunco, facendolo fischiare per l’aria come una spada. Il giunco tagliava di netto fiori e foglie che cadevano pulitamente a terra presso la pianta, lasciando ritti gli steli decapitati. Provava, cosi facendo, un raddoppiamento di vitalità, e quasi il compiacimento delizioso che ispira lo sfogo di un’energia troppo a lungo compressa; ma al tempo stesso non sapeva che sentimento esatto di potenza e di giustizia. Come se quelle piante fossero state colpevoli e lui le avesse punite e avesse insieme sentito che era in suo potere punirle. Ma il carattere proibito e colpevole di questo passatempo non gli era del tutto ignoto. Ogni tanto, quasi suo malgrado, rivolgeva sguardi furtivi alla villa, timoroso che la madre dalla finestra del salotto o la cuoca da quella della cucina potessero osservarlo. E si rendeva conto che temeva non tanto il rimprovero quanto la semplice testimonianza di atti che lui stesso avvertiva anormali e misteriosamente intrisi di colpevolezza. Dai fiori e dalle piante agli animali, il passaggio fu insensibile, come lo è in natura. Marcello non avrebbe potuto dire quando si accorse che quello stesso piacere, che provava nello schiantare le piante e nel decapitare i fiori, gli si rivelava più intenso e più profondo nell’infliggere le stesse violenze agli animali. Forse fu soltanto il caso che lo spinse su questa via, un colpo di giunco che, invece di storpiare un arbusto, colpi sulla schiena una lucertola addormentata su un ramo o forse un principio di noia e di sazietà che gli suggerì di cercare nuova materia sulla quale esercitare la crudeltà ancora inconsapevole. Comunque, un pomeriggio silenzioso che tutti in casa dormivano, Marcello si ritrovò ad un tratto, come colpito da una folgore di rimorso e di vergogna, davanti ad una strage di lucertole. Erano cinque o sei lucertole che con vari modi era riuscito a scovare sui rami degli alberi o sulle pietre del muro di cinta, fulminandole con un solo colpo di giunco proprio nel momento in cui, insospettite dalla sua presenza immobile, cercavano di fuggire verso qualche riparo. Come fosse giunto a questo non avrebbe saputo dire o meglio preferiva non ricordarlo, ma ormai tutto era finito e non restava che il sole ardente e impuro sui corpi sanguinolenti e lordi di polvere delle lucertole morte. Egli stava in piedi davanti al marciapiede di cemento sul quale giacevano le lucertole, il giunco stretto in pugno; e sentiva ancora per il corpo e sul viso l’eccitazione che l’aveva invaso durante la strage, ma non più piacevolmente fervida, come era stata allora, bensì già trascolorante nel rimorso e nella vergogna. Si rendeva conto, inoltre, che al solito sentimento di crudeltà e di potenza si era aggiunto questa volta un turbamento particolare, nuovo per lui, inspiegabilmente fisico; e, insieme con la vergogna e il rimorso, provava un confuso senso di spavento. Come a scoprire in se stesso un carattere del tutto anormale, di cui dovesse vergognarsi, che dovesse mantenere segreto per non vergognarsi oltre che con se stesso anche con gli altri e che, di conseguenza, lo avrebbe per sempre separato dalla società dei coetanei. Non c’era dubbio, egli era diverso dai ragazzi della sua età che, loro, non si dedicavano né insieme né soli a simili passatempi; e per giunta diverso in maniera definitiva. Perché le lucertole erano morte, su questo non c’era dubbio e questa morte e gli atti da lui compiuti, crudeli e folli, per provocarla, erano irreperibili. Egli era, insomma, quegli atti, come in passato era stato altri atti del tutto innocenti e normali. Quel giorno, a conferma di questa scoperta cosi nuova e cosi dolorosa della propria anormalità, Marcello volle confrontarsi con un suo piccolo amico, Roberto, che abitava nel villino attiguo al suo. Verso il crepuscolo, Roberto, dopo aver finito di studiare, scendeva in giardino; e fino all’ora della cena, per mutuo consenso delle famiglie, i due ragazzi giocavano insieme, ora nel giardino dell’uno, ora in quello dell’altro. Marcello aspettò quel momento con impazienza, per tutto il lungo pomeriggio silenzioso, solo in camera sua, disteso sul letto. I genitori erano usciti, in casa non c’era che la cuoca di cui, ogni tanto, udiva la voce che cantarellava sommessamente nella cucina, al pianterreno. Di solito, il pomeriggio, studiava o giocava, solo nella propria camera; ma quel giorno né gli studi né il gioco l’attraevano; si sentiva incapace di fare quel che sia e al tempo stesso furiosamente insofferente dell’ozio: lo paralizzavano e, insieme, lo spazientivano lo sgomento della scoperta che gli pareva di aver fatto e la speranza che questo sgomento venisse dissipato dal prossimo incontro con Roberto. Se Roberto gli avesse detto che anche lui uccideva le lucertole e che gli piaceva ucciderle e non vedeva alcun male nell’ucciderle, gli sembrava che ogni senso di anormalità sarebbe scomparso e che egli avrebbe potuto guardare con indifferenza alla strage delle lucertole come ad un incidente privo di significato e senza conseguenze. Non avrebbe saputo dire perché attribuisse tanta autorità a Roberto; oscuramente pensava che se anche Roberto faceva di queste cose e in quel modo e con quei sentimenti, questo voleva dire che tutti le facevano; e quel che tutti facevano era normale ossia bene. Queste riflessioni non erano, d’altronde, ben chiare nella mente di Marcello e gli si presentavano piuttosto come sentimenti e impulsi profondi che come pensieri precisi. Ma di un fatto gli pareva di essere sicuro: dalla risposta di Roberto dipendeva la tranquillità del suo animo. In questa speranza e in questo sgomento, aspettò con impazienza l’ora del crepuscolo. Stava quasi per assopirsi, quando, dal giardino, gli giunse un lungo fischio modulato: era il segnale convenuto con il quale Roberto l’avvertiva della sua presenza. Marcello si levò dal letto e, senza accender luci, nella penombra del tramonto, usci dalla camera, discese la scala e si affacciò al giardino. Nella luce bassa del crepuscolo estivo gli alberi stavano immobili e aggrondati; sotto i rami, l’ombra appariva già notturna. Esalazioni floreali, odor di polvere, irradiazioni solari emananti dalla terra riscaldata stagnavano per l’aria immobile e densa. La cancellata che divideva il giardino di Marcello da quello di Roberto scompariva completamente sotto un’edera gigantesca, folta e profonda, simile ad un muro di foglie sovrapposte. Marcello andò dritto ad un angolo in fondo al giardino dove l’edera e l’ombra erano più fitte, sali in piedi su un grosso sasso e con un solo gesto deliberato scostò tutta una massa del rampicante. Era stato lui ad inventare quella specie di sportello nel fogliame dell’edera, per un senso di gioco segreto e avventuroso. Spostata l’edera, apparvero le sbarre della cancellata e, tra le sbarre, il viso fine e pallido, sotto i capelli biondi, dell’amico Roberto. Marcello si alzò in punta di piedi sul sasso e domandò : « Nessuno ci ha visti ? » Era la formula d’inizio di questo loro gioco. Roberto rispose come recitando una lezione : « No, nessuno... ». E poi dopo un momento: «Hai studiato tu? » Parlava sussurrando, altro procedimento convenuto. Sussurrando anche lui, Marcello rispose: «No, oggi non ho studiato... non avevo voglia... dirò alla maestra che mi sentivo male ». «Io ho scritto il compito di italiano», mormorò Roberto, « e ho fatto anche uno dei problemi di aritmetica... me ne resta un altro... perché non hai studiato? » Era la domanda che Marcello si aspettava : « Non ho studiato», rispose, « perché ho dato la caccia alle lucertole ». Sperava che Roberto gli dicesse: «Ah davvero.. anch’io qualche volta do la caccia alle lucertole», o qualche cosa di simile. Ma il viso di Roberto non esprimeva alcuna complicità e neppure curiosità. Soggiunse con sforzo, cercando di dissimulare il proprio imbarazzo: « Le ho uccise tutte ». Roberto prudentemente domandò : « Quante ? » « Sette in tutto », rispose Marcello. E poi, sforzandosi ad una vanteria tecnica e informativa : « Stavano sui rami degli alberi e sui sassi... io ho aspettato che si muovessero e poi le ho colte a volo... con un solo colpo di questo giunco... un colpo per una». Fece una smorfia di compiacimento e mostrò il giunco a Roberto. Vide l’altro guardarlo con una curiosità non disgiunta da una specie di meraviglia : « Perché le hai ammazzate ? » « Cosi », egli esitò, stava sul punto di dire : « perché mi faceva piacere », poi non sapeva neppur lui perché, si trattenne e rispose : « perché sono dannose... non lo sai che le lucertole sono dannose? » « No », disse Roberto « non lo sapevo... dannose a che cosa? » « Mangiano l’uva », disse Marcello, « l’altr’anno in campagna, hanno mangiato tutta l’uva della pergola ». « Ma qui non c’è uva ». « E poi », egli continuò senza curarsi di raccogliere l’obbiezione, « sono cattive... una, come mi ha visto, invece di scappare, mi è venuta addosso con la bocca spalancata... se non l’avessi fermata a tempo, mi saltava addosso... ». Egli tacque un momento e poi, più confidenzialmente, soggiunse: «Tu non ne hai mai ammazzate? » Roberto scosse il capo e rispose: «No, mai». Quindi abbassando gli occhi, compunto in viso: « Dicono che non bisogna far male agli animali». « Chi lo dice ? » « La mamma ». « Dicono tante cose... », disse Marcello sempre meno sicuro di sé, « ma tu prova, stupido... ti assicuro che è divertente». « No, non proverò». « E perché ? » «Perché è male». Cosi non c’era niente da fare, pensò Marcello con disappunto. Gli venne un impeto d’ira contro l’amico che, senza rendersene conto, lo inchiodava alla propria anormalità. Riuscì tuttavia a dominarsi e propose : « Guarda, domani rifaccio la caccia alle lucertole... se tu vieni a dar la caccia con me, ti regalo il mazzo delle carte del Mercante in Fiera». Sapeva che per Roberto l’offerta era tentante : aveva più volte espresso il desiderio di possedere quel mazzo. E infatti Roberto, come illuminato da una subita ispirazione, rispose : « Io vengo a caccia ma a un patto: che le prendiamo vive e poi le chiudiamo in una scatolina e poi le lasciamo libere... e tu mi dai il mazzo ». « Questo no », disse Marcello, « il bello sta proprio nel colpirle con questo giunco... scommetto che non ne sei capace ». L’altro non disse nulla. Marcello prosegui: «Allora vieni... siamo intesi... ma cercati anche tu un giunco ». « No », disse Roberto con ostinazione, « non verrò ». « Ma perché? È nuovo quel mazzo ». « No, è inutile » disse Roberto « io le lucertole non le ammazzo... neppure se», egli esitò cercando un oggetto di un valore proporzionato, « neppure se mi dai la tua pistola ». Marcello comprese che non c’era niente da fare e tutto ad un tratto, si lasciò andare all’ira che gli bolliva da qualche momento nel petto : « Non vuoi perché sei un vigliacco», disse, «perché hai paura». « Ma paura di che? Mi fai proprio ridere ». « Hai paura » ripetè Marcello adirato « sei un coniglio... un vero coniglio». Improvvisamente, sporse una mano attraverso le sbarre della cancellata e afferrò l’amico per un orecchio. Roberto aveva orecchie sporgenti, rosse, e non era la prima volta che Marcello gliele afferrava; ma mai con tanta rabbia e con un desiderio cosi preciso di fargli male. « Confessa che sei un coniglio». « No, lasciami », cominciò a lamentarsi l’altro torcendosi, « ahi... ahi ». « Confessa che sei un coniglio ». « No... lasciami ». « Confessa che sei un coniglio ». Nella sua mano l’orecchio di Roberto bruciava, caldo e sudato; lagrime apparvero negli occhi azzurri del tormentato. Egli balbettò : « Si, va bene, sono un coniglio », e Marcello lo lasciò subito. Roberto saltò giù dalla cancellata e correndo via gridò: « Non sono un coniglio... mentre lo dicevo ho pensato: non sono un coniglio... te l’ho fatta». Scomparve, e la sua voce, lagrimosa e beffarda, si perse lontano, oltre i boschetti del giardino attiguo. Gli restò da questo dialogo un senso di malessere profondo. Roberto, insieme con la sua solidarietà, gli aveva negato l’assoluzione che egli cercava e che gli sembrava legata a quella solidarietà. Cosi, era respinto nell’anormalità; ma non senza aver prima mostrato a Roberto quanto gli premesse uscirne, ed essersi lasciato andare, come si rendeva conto perfettamente, alla menzogna e alla violenza. Adesso alla vergogna e al rimorso di aver ucciso le lucertole, si aggiungeva la vergogna e il rimorso di aver mentito a Roberto circa i motivi che lo spingevano a chiedergli la sua complicità e di essersi tradito con quel movimento di ira, quando l’aveva afferrato per l’orecchio. Alla prima colpa se ne aggiungeva una seconda; e lui non poteva disfarsi in alcun modo né dell’una né dell’altra. Ogni tanto, tra queste riflessioni amare, riandava con la memoria alla strage delle lucertole, quasi sperando di ritrovarla depurata di ogni rimorso, un semplice fatto come un altro. Ma subito si accorgeva che avrebbe voluto che le lucertole non fossero mai morte; e, insieme, vivo e, forse non del tutto spiacevole ma, appunto per questo, tanto più ripugnante, gli tornava quel senso di eccitazione e di turbamento fisico che aveva provato mentre dava la caccia; tanto forte da fargli persino dubitare che avrebbe resistito nei giorni prossimi alla tentazione di ripetere la strage. Questo pensiero lo atterri: cosi, non soltanto egli era anormale, ma, nonché di sopprimere l’anormalità, non era neanche capace di controllarla. Era in quel momento in camera sua, seduto al tavolino, davanti un libro aperto, in attesa della cena. Impetuosamente si alzò, andò al letto, e gettandosi in ginocchio sullo scendiletto, come era solito fare quando recitava le preghiere, disse ad alta voce, giungendo le mani, con accento che gli parve sincero : « Giuro davanti a Dio che non toccherò mai più né i fiori, né le piante, né le lucertole ». Tuttavia, il bisogno di assoluzione che l’aveva spinto a ricercare la complicità di Roberto sussisteva; cambiato adesso nel suo contrario, in un bisogno di condanna. Roberto, mentre avrebbe potuto salvarlo dal rimorso schierandosi al suo fianco, non aveva abbastanza autorità per confermare la fondatezza di questo rimorso e metter ordine nella confusione della sua mente con un verdetto inappellabile. Era un ragazzo come lui, accettabile come complice ma inadeguato come giudice. Ma Roberto, rifiutando la sua proposta aveva addotto, a sostegno della propria ripugnanza, l’autorità materna. Marcello pensò che si sarebbe appellato anche lui a sua madre. Lei soltanto poteva condannarlo o assolverlo e, comunque, far rientrare il suo atto in un ordine purchessia. Marcello che conosceva sua madre, prendendo questa decisione, ragionava in astratto, come riferendosi ad una madre ideale, quale avrebbe dovuto essere e non qualora. In realtà, dubitava del buon esito del suo appello. Ma tant’era, egli non aveva che quella madre e d’altronde il suo impulso a rivolgersi a lei era più forte di qualsiasi dubbio. Marcello aspettò il momento in cui la madre, dopo che si era coricato, veniva in camera a dargli la buonanotte. Era questo uno dei pochi momenti che gli riusciva di vederla da solo a solo: il più delle volte, durante i pasti o nelle rare passeggiate coi genitori, il padre era sempre presente. Marcello, sebbene non avesse, d’istinto, molta fiducia nella madre, l’amava e, forse, anche più che amarla, l’ammirava in maniera perplessa e invaghita, come si ammira una sorella maggiore dalle abitudini singolari e dal carattere estroso. La madre di Marcello, che si era sposata giovanissima, era rimasta moralmente e anche fisicamente una fanciulla; inoltre, pur non avendo alcuna confidenza con il figlio di cui si occupava pochissimo a causa dei numerosi impegni mondani, ella non aveva mai separato la propria vita da quella di lui. Cosi Marcello era cresciuto in un continuo tumulto di entrate ed uscite precipitose, di vestiti provati e gettati via, di interminabili quanto frivole conversazioni al telefono, di bizze con sarti e fornitori, di dispute con la cameriera, di continue variazioni di umore per i più futili motivi. Marcello poteva entrare in camera di sua madre in qualsiasi momento, spettatore curioso e ignorato di un’intimità in cui non aveva alcun posto. Qualche volta la madre, come riscuotendosi dall’inerzia per un improvviso rimorso, decideva di dedicarsi al figlio e se lo portava dietro da una sarta o da una modista. In queste occasioni, costretto a passare lunghe ore seduto sopra uno sgabello, mentre la madre provava cappelli e vestiti, Marcello quasi rimpiangeva la solita turbinosa indifferenza. Quella sera, come comprese subito, la madre aveva più fretta del solito; e infatti, prima ancora che Marcello avesse avuto il tempo di sormontare la propria timidezza, ella gli voltò le spalle avviandosi, attraverso la camera buia, alla porta rimasta socchiusa. Ma Marcello non intendeva aspettare ancora un giorno il giudizio di cui aveva bisogno. Tirandosi a sedere sul letto, chiamò con voce forte: « Mamma ». La vide voltarsi dalla soglia, con gesto quasi infastidito. «Che c’è, Marcello?» ella domandò, poi, avvicinandosi di nuovo al letto. Ora stava in piedi presso di lui, in controluce, bianca e esile nel nero abito scollato. Il viso fine e pallido incorniciato di capelli neri era in ombra, non tanto però che Marcello non vi distinguesse un’espressione scontenta, frettolosa e impaziente. Tuttavia, trasportato dal suo impulso, egli annunziò: «Mamma, debbo dirti una cosa ». « Si Marcello, ma fa presto... la mamma deve andar via... il papà sta aspettando ». Intanto con le due mani armeggiava sulla nuca, intorno il fermaglio della collana. Marcello voleva rivelare alla madre la strage delle lucertole e domandarle se aveva fatto male. Ma la fretta materna gli fece cambiar idea. O meglio, modificare la frase che aveva preparato in mente. Le lucertole gli parvero ad un tratto animali troppo piccoli e insignificanti per poter fermare l’attenzione di una persona cosi distratta. Li per li, non sapeva neppur lui perché, inventò una bugia ingrandendo il proprio delitto. Sperava con l’enormità della colpa di riuscire a colpire la sensibilità materna che, in maniera oscura, indovinava ottusa e inerte. Disse con una sicurezza che lo meravigliò : « Mamma, ho ucciso il gatto ». In quel momento la madre era riuscita finalmente a fare incontrare le due parti del fermaglio. Le mani riunite sulla nuca, il mento inchiodato sul petto, ella guardava a terra e ogni tanto, per l’impazienza, batteva il tacco sul pavimento. «Ah si », disse con voce incomprensiva, come svuotata di ogni attenzione dallo sforzo che stava facendo. Marcello ribadì, malsicuro: «L’ho ucciso con la fionda». Vide la madre scuotere il capo con disappunto e poi togliere le mani dalla nuca, tenendo in una la collana che non era riuscita a chiudere. « Questo maledetto fermaglio», ella proferì con rabbia, «Marcello... da bravo... aiutami a metter la collana». Ella sedette sul letto, di sbieco, le spalle al figlio, soggiungendo con impazienza: « Ma sta attento a far scattare il fermaglio... altrimenti si aprirà di nuovo ». Pur parlando, gli presentava le spalle magre, nude fino alle reni, bianche come la carta nella luce che veniva dalla porta. Le mani sottili dalle unghie aguzze e scarlatte tenevano il monile sospeso sulla nuca delicata, ombreggiata di peluria ricciuta. Marcello si disse che, una volta attaccata la collana, ella l'avrebbe ascoltato con maggiore pazienza; sporgendosi, prese i due capi e li saldò con un solo scatto. Ma la madre si levò subito in piedi e disse chinandosi a sfiorargli il viso con un bacio: "Grazie... ora dormi... buonanotte." Prim'ancora che Marcello avesse potuto trattenerla con un gesto o con un grido, era già scomparsa. |